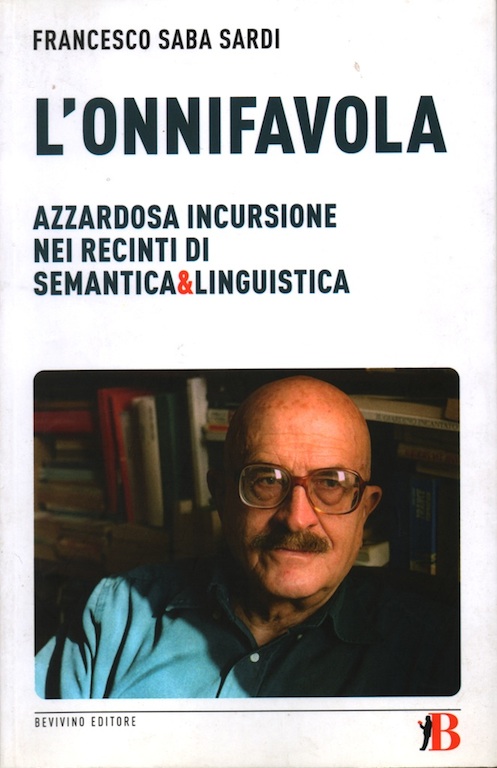Certe favole/Storia – di Francesco Saba Sardi
Tutti i diritti riservati©Bevivino Editore
CERTE FAVOLE
Storia.
Il potere abolisce la fatalità. Nelle sue versioni scientifiche permette addirittura la vittoria sulla morte. Al cittadino viene infusa la speranza che davvero il meglio «ha da venire»; il futuro ha preso il posto del passato. Si tratta infatti di prevedere esattamente, e pertanto di dirigere e condizionare l’avvenire. Dunque, prevedere ciò che la finalità avrebbe in serbo e condizionare il destino per gabbarlo. Per farlo, occorre proiettare nel divenire il già avvenuto, ricavandone le regole del cammino umano, però depurandolo di quanto rischi di smentirle: le eccezioni, da considerare troppo rare per ricavarne attendibilità, o comunque superabili, cioè spiegabili e giustificabili.
Ne è esempio sovrano lo strumento delle neoconquiste, non solo territoriali ma, di riflesso, tutte quelle designano e impongono la strada maestra da percorrere, in base a previsioni dichiarate, fideisticamente, indiscutibili. Lo strumento in questione – la sovrapposizione cioè del passato all’avvenire che cessa di essere ignoto per diventare trasparente – ha permesso di immaginare un’epoca nuova, quella del colonialismo postmedievale, l’era delle neoconquiste. Queste hanno assicurato il predominio del Discorso, soprattutto nella versione occidentale, nel globo, con la progressiva distruzione di quanto è è apparso ostile alla logico-discorsività, la sylva estranea alla polis. Cataclismatico evento che ha comportato una radicale trasformazione del mondo, quel capovolgimento – relativamente recente – di cui siamo gli eredi, non di rado – in quanto occidentali – consenzienti, compiaciuti e compartecipi o per lo meno passivi e accomodanti spettatori.
Uno strumento consistente, in sostanza, nella storiografia. Più precisamente, nella sua forma – cronaca. Termine che notoriamente deriva dal latino chronica (neutro plurale nel latino medievale divenuto femminile singolare) e dal greco chroniká, «ciò che riguarda il tempo». Ora, la storiografia in tutte le sue eccezioni, si fonda sempre e comunque sull’interpretazione del tempo concepito quale un’entità che si srotola parallelamente alle vicende umane; si dice infatti, molto spesso, che times are changing, (cambierebbero il ritmo di discesa della sabbia nelle clessidre), l’entità tempo essendo mutevole. Il tempo, anzi il tempo-spazio di einsteiniana invenzione e l’universo, sono intesi come equivalenti: tempo che inizia, tempo che si svolge, tempo che forse ha una conclusione (e lo ha senz’altro nelle visioni religiose).
Durante il medioevo occidentale e bizantino la cronaca fu l’unica effettiva forma storica, rimasta fedele al modulo annalistico della storiografia romana, e perdurato anche durante la rinascenza carolingia e in epoca post-carolingia, in cui risorse l’interesse per l’esposizione degli eventi in sequenza cronologica. In parte, con l’abbandono di quella fusione di mitolgia, o meglio elaborazione leggendaria, illustrante accadimenti concreti, che aveva caratterizzato non solo la «storia» antico-classica ma, più in generale, l’intera veterostoria, sia l’europea che l’indiana, sia cinese che egiziana o mesopotamica… Una narrazione che metteva in scena personaggi proposti come esempi da imitare, incarnazioni di programmi metafisici o più terrenamente ideologici, dunque uomini e donne che fossero riusciti a somigliare a modelli «sacri» (dei, semidei, eroi mitologici) o «sacralizzati», cioè rispondenti alle esigenze dei poteri, soprattutto religioni, o che si prestassero a essere a loro volta deificati o perlomeno esaltati in quanto degni di adorazione: padri della patria, per esempio. Ed era una storia che di proposito celebrava le virtù dei sovrani, che ne proclamava la grandezza più che umana e relegava i sudditi nell’ombra.
Gli eventi riportati nelle iscrizioni, nelle storie orali, nei libri vittoriali di tutto il mondo (e basti pensare al pui, il libro orale degli eroi dei Soninke, sottogruppo dei Mande dell’Africa occidentale, che nel XIII secolo fondarono il grande impero del Mali) erano una esposizione di paradigmi, di nobili archetipi, la messa in scena di «uomini illustri». Ed erano questi a generare gli eventi avvalendosi di altri uomini concepiti quali meri strumenti variamente e agevolmente «spendibili».
La cronaca, in altre parole, considerava secondario il fatto storico (uso il termine con l’avvertimento che il «fatto» esiste solo in quanto già detto, narrato, cantato, come ben sa qualunque giornalista moderno).
C’è da chiedersi – e affronterò più avanti l’interrogativo – se quella che chiamiamo storia, intendendola come una disciplina che aspira alla «verità», alla corrispondenza scientifica tra fatto e fattuità (evidenza cioè dell’avvenuto e della sua esatta riproduzione: cartografie degli eventi coincidente con questi) sia per caso rimasta ciò che era allora. E, più ancora, se sia possibile o immaginabile concepire il dipanarsi di un’epoca, la narrazione di una catastrofe, la designazione di punti nodali del divenire in termini che non si riducano alla loro indicazione come realtà indiscutibili fideisticamente tali, che dunque si stagliano su fondali assai più magmatici che l’artefice dell’opera o dell’impresa lascia semplicemente sussistere in quanto privi di importanza primaria. Potrei invocare folle di esempi. Mi limito ad alcuni, particolarmente indicativi.
Ecco i due libri vetero-testamentari 1 Maccabei e 2 Maccabei che illustrano la lotta dell’ortodossia ebraica contro l’ellenismo ormai imperante. In effetti, i loro autori intendevano raccontare una storia religiosa, una favola teologica, ricalcando antiche cronache di Israele, la vicenda dei fratelli Maccabei, artefici della rivolta contro la Siria passata così in secondissima linea rispetto all’effettivo intento, quello di proclamare il dominio stoico sulle passioni, in una sorta di «modernizzazione» e «attualizzazione» del pensiero ebraico che ormai risentiva in lunga misura di quello ellenistico.
Ed ecco la vicenda della grande battaglia di Qadesh combattuta dall’esercito egizio guidato dal faraone Ramses II nel 1308 circa a.C. contro gli Ittiti. Che ne uscirono vincitori, tant’è, come si legge nelle cronache coeve, che il faraone dovette ritirarsi verso la Palestina. In Egitto venne però ripetutamente celebrato in scritti e grandi composizioni plastiche in cui appare trionfatore ed è sempre lui che travolge, da solo, il nemico, lo insegue e lo stermina frecciando o colpendo dal suo carro da guerra, uccide i prigionieri, eccetera. Lui solo.
In generale il potere è simbolicamente inteso, sempre e comunque, quale uomo solo dominatore dei sudditi configurati come un uomo solo collettivo chiamato a obbedire al turannos, il fallocrate, monocrate o democratico che sia, il linga-Shiva, il rex ( e-re-zione, rex erectus est, cioè intronizzato): il potere, dicevo, non può essere diverso da se stesso. La storiografia dà semplicemente atto di questa «realtà» consistente nella letteralizzazione favolistica della sua indispensabilità: i suoi giochi, solitari o in compagnia di altri turannoi volti ad affermare la loro qualità di betili, pietre fitte figurate, senza cedere all’avvicendarsi delle costellazioni; e dei decreti del tempo-destino. Come dire, ripeto, che la storiografia racconta le posizioni assunte nella mappa celeste dalle galassie e la risposta dall’uomo – fallo che si sottrae ai loro decreti, ostinandosi a concludere la sua ventura sul letto di morte – o sul campo di battaglia o sulla poltrona finale quale vincitore o perdente, ma comunque perno della vicenda. Nella quale libertà, democrazia, tolleranza, condivisione dei poteri, parlamenti, opposizioni, uccisioni dei tiranni o loro celebrazione, colpi di stato, elezioni, e tutto ciò che interviene nello svolgimento, presuntamente effettivo (la sua «realtà» essendo confermata dalla storiografia, cioè da se stessa) del gioco del potere. Il ludus che si reitera, restando sostanzialmente uguale fin dal neolitico.
Ma torniamo alle conseguenze della cronaca, quella che è poi l’essenza della storiografia nella sua immutabilità e ripetività. Da cui si distacca solo la poiesis, ammesso che non si riduca a targa celebrativa.
Il proposito di ricordare le azioni umane e le loro conseguenze era probabilmente ignoto prima del neolitico, durante cioè le epoche che chiamiamo proprio per questo preistoriche o astoriche, e starebbe a dimostrarlo l’assenza di interessi del genere presso gli attuali primitivi, posto che si possano attribuire le loro costumanze ai cacciatori e raccoglitori itineranti paleolitici. I primi esempi di narrazioni grafite su sostegni di vario tipo o figurate (incisioni, sculture…) che, riferendo eventi dati per effettivamente accaduti, promuovevano un ideale che andava al di là delle vicende belliche e degli intrighi politici (e sono comunque l’affermazione della logico-discorsività nelle particolari versioni nazionali) risalgono al sesto millennio a. C. in Cina, al quinto in Mesopotamia, non prima del terzo in India e nel mondo mediterraneo.
E molto spesso prendevano le mosse addirittura dalla nascita dei primi uomini. Fu l’umanesimo, pertanto in epoca assai vicina a noi, a introdurre una visione parzialmente diversa, non più leggendaria e unicamente celebrativa: sotto la spinta di interessi economici e politici si continuerà, è vero, a immaginare il personaggio come motore principale degli eventi, a sua volta sottomesso al destino o, più correttamente, alla volontà divina, e si continuò a trascurare l’apporto di quello che oggi chiameremmo il popolo o le masse; ma per lo meno si conferì agli «uomini illustri» quasi una psicologia, una fisionomia tale da sembrare precisa o per lo meno accettabile.
L’Umanesimo segnò così l’esordio della storiografia quale possiamo intenderla oggi, vale a dire interpretazione dei fatti avente per bussola la consapevolezza di una problematica appunto storica o per meglio dire rispondente a una cronologia, e dunque di un significato da attribuire agli eventi e alle loro cause. Nell’uso premoderno si parlava di cronaca in contrapposizione a storia, intendendo la prima quale un’esposizione di semplici fatti dovuta all’azione e agli intenti di singoli «eroi», i cui scopi e le cui giustificazioni, insomma i loro valori e la loro efficacia, andavano pur sempre riferiti ai decreti da leggere nella volontà divina, nelle stelle, nella struttura stessa dell’universo.
Ma soltanto in esempi a noi vicinissimi, in pratica solo nel Settecento, ci si è convinti che a dettare le azioni umane erano le idee, cioè le invenzioni, altrettanto autonome rispetto ai decreti delle stelle quanto le produzioni artistiche.
Come dicevo, le cronache sono servite, per secoli, a giustificare le neoconquiste, in particolari le tardomedievali; quelle dell’epoca di massima fioritura delle cronache stesse (si pensi, per esempio, ai Commentari reali degli Incas e alla Storia generale del Perù di Garcilaso de la Vega detto El Inca). Che si sono differenziate delle paleoconquste per la loro totalitarietà e a esclusività, proporzionate alle potenzialità offerte dalla comparsa sulla scena mondiale di nuovi strumenti di sottomissione: inedite strutture sociali, imprecedute concezioni del dominio e dei rapporti tra i singoli, eserciti creati ex novo, armi inventate proprio ai fini di imprese di nuovo tipo, impossibili con i mezzi di altre epoche.
Se infatti Roma deportava schiavi, schiavisti erano anche i regni e gli aggregati tribali, le nazioni alle quali imponeva la propria superiorità. E se aveva conquistato l’Egitto, ne aveva però integrato numerosi aspetti religiosi e genericamente culturali. Non aveva ridotto in polvere il paese dominato limitandosi a farne una provincia dell’impero. E Roma, ferus victor, si era lasciata sedurre e «catturare» dalla cultura greca.
Il punto di svolta definitivo, la componente decisiva, la premessa sine qua non delle neo-conquiste, fu l’affermazione dei monoteismi nel mondo tardo-antico e medievale. Alle spalle delle invasioni e colonizzazioni tardo-medievali e post-medievali furono, accanto ai mezzi più efficaci di cui si è detto, inedite spinte ideologiche, cioè appunto i monoteismi cristiano e islamico, con i corollari che ne derivarono. Tra i quali in primo luogo il riemergere per riflesso o constatata utilità, di aspirazioni monoteistiche in altre parti del mondo, o per lo meno il diffondersi di religioni implicitamente monoteistiche al di là dei perduranti, tradizionali politeismi, come in India, in Cina, in Giappone: religioni cioè saldamente incentrate su una divinità o gruppi di divinità dotate di poteri assolutistici, del resto conformi alle concentrazioni socio-politiche in atto nei rispettivi paesi.
Cosa che ebbe per effetto un accorpamento della sacralità diffusa, di numi, dei, spiriti, geni, credenze locali, in un’unitaria fusione con la quale coincideva senza residui la struttura sociale. Cosa che soprattutto comportò la desacralizzazione del mondo, la sua demitizzazione: una ancora inesplicita, certo, ma non per questo meno concreta laicizzazione. In altre parole, l’affermarsi del logos a spese della mitologia e, attraverso queste, del mito. L’avviata riduzione del molteplice all’Uno, l’istituzione di un dominio uni-versale, la soppressione dell’altro ipostatizzato dall’infedele, dal selvaggio, dal primitivo, dal cannibale…
E la riduzione all’Uno è appunto ciò che ha raccontato, e racconta, la Storia, soprattutto nelle sue versioni moderne.
Che è quanto dire: lo scopo al quale mira il Dominio nelle sue metastasi, che sono politica, intesa propriamente come tale, religione, guerra.
Va però detto che se nel mondo che diciamo moderno prevale la concezione dell’autonomia delle decisioni umane dalla metafisica, questa, cacciata dalla porta, è prontamente rientrata dalla finestra. È infatti tutt’altro che superata la convinzione che le idee sono create da forze sociali, e non viceversa, non dunque forze sociali messe in azione dalle idee. Se il mondo è stato colonizzato dall’occidente, ciò è avvenuto – così recita questo mantra – perché la struttura sociale delle aree extraeuropee era tale da esigere l’intervento dei conquistadores, dei missionari, degli sfruttatori delle risorse locali, che altrimenti sarebbero rimaste ignorate o inutilizzate.
È, per esempio, il mantra marxista delle produzioni intellettuali e artistiche cresciute su un piedistallo, la «base» di concretezze socio-economiche. È certamente innegabile che sono singoli individui a inventare le idee che muovono gli eventi, ma è anche palese che le idee nascono o possono mettere radici, venire accettate, diffuse, moltiplicate, affermarsi e produrre cambiamenti e finanche quelle che chiamiamo rivoluzioni, se rispondono a circostanze favorevoli, se sono semi fertili sparsi e radicantisi in un terreno fecondo. Ma sarebbe vana fatica tentare di confutare simili forme di tardomarxismo o di religioni o paralegioni affini, che insistono ad attribuire l’invenzione a enti extraumani o alla «forza delle cose», ovviamente invincibile. Arduo combattere contro i pregiudizi.
Ma se le cronache medievali e postmedievali hanno avuto l’ominosa funzione di indicare i luoghi, i popoli, le condizioni materiali di intere regioni che offrissero, se conquistate, possibilità di arricchimento, gloria, rafforzamento dei poteri, in una parola l’attuazione di aspirazioni imperialistiche, non mancano certo equivalenti moderni delle cronache. Ne cito alcuni: l’astrofisica, che ha concepito un universo «nato» da un Big-Bang, che forse è anzi un multiuniverso, qualcosa di simile Ai mille mondi et uno nella versione del credente Giordano Bruno: universi con strutture e «leggi» particolari; l’astrofisica si dà da fare per trovare pianeti adatti alla vita di esseri umani prima o poi costretti ad abbandonare una terra troppo popolata, troppo sfruttata, ormai in agonia. E ha immaginato, accanto alla sua «nascita», la certa «morte» dell’universo o di una sua provincia a opera per esempio di buchi neri onnidivoranti o di conflitti intergalattici. E intanto manda in giro satelliti e telescopi, e ha già mandato nell’extraspazio astronauti, bestiole e vegetali. E ispira, oltre a rinnovate ipotesi, narrazioni e film. È difficile distinguere la scienza astrofisica dalla fantascienza. Che pertengano entrambe alla favolistica?
A far da complemento alla fantascienza, ci sono gli acceleratori di particelle che dovrebbero spiegarci com’è fatta il mondo, cosa siamo, perché siamo e dove andiamo.
Ma sì, altrettante neofavole aventi la stessa funzione delle paleofavole. Altrettante potenziali neoconquiste. E comunque strumenti di potere e riaffermazione di un Dominio che è sempre più autoreferente, sempre più dilagante, sempre più distruttiva.
Certo è che la diffusione delle neofavole, e tanto più di quella supremamente tradizionale, la Storia, comporta l’affermazione di uni-teismi e contribuisce ai trionfi della gerarchia. Se parlo di suprema tradizione della Storia è perché allo storiografo, interprete e sacerdote dello svolgimento degli eventi, sono stati svelati gli arcani. Tutto costui ha problematizzato.
E non conosce solo il passato – le cose sono andate proprio così!, ma il futuro gli si apre intatto davanti. E sa che passato e futuro esistono, e infatti li definisce, sia pure servendosi di una determinazione che presuppone se stessa: dice che il passato è un non-più, il futuro un non-ancora, il presente è l’adesso. Tre momenti che presuppongono una concezione del tempo, la Zeit in tedesco (in seguito rifletterò sui generi delle determinazioni favolo-scientifiche), che contengono una negatività, il passato perché non è più, il futuro perché non è ancora, il presente perché, nell’istante in cui si lo si coglie, è già trapassato nel non-più. Sicché, i momenti del tempo appaiono come non-esistenze, e tuttavia il tempo è realtà. Tant’è che il favolista-storico lo smembra in fasi alle quali sa porre precisi paletti: evo antico, spentosi in data tale, evo intermedio definito tra questa data o quell’altra, e così via.
Ma se lo fa, è perché tende a qualcosa, alcunché lo sospinge, lo incalza, lo mette in tensione, e a ben guardare il motore della tensione è l’aspirazione a un aldilà. A ciò che sta fuori dal tempo, quello che i greci chiamavano a-idion, non un’entità concreta, bensì una visione astratta, scissa da lui – da noi –, quella forza di tensione che fa sorgere la realtà: il divino che crea (macchè inventa, che è cosa umana: ma sì crea – il mondo). E astratta è la visione dello storico perché spezzetta il divenire umano. Ne fa tanti capitoli, che hanno una singolare somiglianza con i generi letterari. Si ha così il medioevo, e lo storico ce lo descrive appunto in termini medievali-letterari, volendo dircene le caratteristiche che lo rendono tale, e che sono ben diverse da quelle, che so, del Rinascimento. Ciascun genere ben delimitato, e una scissione, uno iato, lo isola dal precedente e dal successivo.
Lo storico è mosso da un desiderio di separatezza, vuole formulare un mondo fatto di tanti giardini in successione temporale, e non solo. Perché, a partire da questi pezzi di terra conchiusi (ogni epoca il «suo giardino») vorrebbe dedurre giudizi universali. Ma l’idea di accettare codesta frammentazione, dimenticando il mondo «che è fuori», impedendo alla «realtà» di irrompere oltre cancelli e muri, ne fa altrettanti luoghi falsi, appunto favolistici. E le favole possono ben essere deliziose e fungere da interpretazione del tutto, ma sono impossibili da vedere, toccare, sperimentare. Sono congetturali, non certo noumentiche.
È da invidiare, lo Storico. Perché si esprime in paragrafi isolati l’uno dall’altro, tanti disiecta membra, storie isolistiche come se non ci fosse continuità che vada al di là della panoramica letteraria. Eccolo infatti rivelarci la differenza tra l’epoca in cui il Cristianesimo aveva tutte le caratteristiche del Cristianesimo, quello «vero», quello degli esordi, e la successiva confusione di sacro impero e di profano, imposta dal Cristianesimo stesso. Per il quale la profanazione finiva per ridentificarsi con la trasgressione la quale, anziché essere accolta ed esaltata in quanto dava accesso alla sacralità, veniva respinta e denunciata come appartenente al mondo diabolico e profano, antisacro. Né lo storico si è avveduto (se non, forse, in tempi recentissimi) che così facendo condannava l’oggetto dei suoi studi e se stesso – al pari di ogni religione rivelata – al vuoto formalismo. La sacralità essendo ridotta alla parte in luce, Dio, mentre ne era esclusa quella in ombra, Satana, il cristianesimo doveva di necessità ricorrere a un enorme apparato logico per sostenere la credenza in questa mutilata sacralità; e dove finiva l’apparato logico, finiva (e finisce) anche il cristianesimo.
Né lo storico mosso dallo spirito della frammentazione e della precisa separazione ha avuto occhi per vedere che proprio l’ambito cristiano costituiva la culla ideale della scienza moderna, dal momento che la chiesa aveva già provveduto a togliere di mezzo la contemplazione del sacro. Perseguitando i culti satanici, non ha fatto che eliminare l’aura di intoccabilità che gravava sulle cose sacre, il «doversi le cose sacre sotto enigmatici velamenti e poetica dissimulazione coprare,» come sosteneva Giovanni Pico della Mirandola. Sempre mosso da brama di frammentazione, lo storico non si avvede che non già il logos si è spinto conquistador, nell’aldilà, ma che, girando su se stesso, ha riempito, ragno indefesso, di una tela sempre più fitta l’ambito dell’aldiqua. E i confini sono sempre quelli: nelle fauci spalancate del cadavere, il logos ributta a precipitarsi. Vana è stata pertanto la fatica dell’antropologia: il tabù non è stato tolto di mezzo, la triade logos-letteratura-discorsività si è logorata nell’opera di cancellare il mitico, ombra che il logos è convinta di essersi lasciata alle spalle, ma che non cessa di inseguirlo, ridendo della sua insufficienza.
Voglio dire, insomma, che tout ne tient: il fallimento del logos è à tout azimout. La favola letteralistica sta tentando, da qualche secolo a questa parte, di imporre il proprio dominio persino nell’ambito dell’erotismo, un tempo ritenuto insudditabile, peccaminosamente tale, condannabile, deprecabile, ma almeno risparmiato dai discorsi della sessuologia e della riduzione alla manicomiabilità delle ricerche sulle perversioni. E le guerre sono sempre più feroci.
Dimostrando le deprecabilità di miti misterici e orgiastici, attribuiti in esclusiva a pagani, pazzi, selvaggi e moderni sporcaccioni, lo storico nella sua legittima veste di, sia pure involontaria, crociato esaltatore del Bene, ha mosso guerra a tutte le manifestazioni della sacralità intesa come violenza e disordine. Non è rimasto, allo storico – moralista, che celebrare il lecito, il depurato, l’igienistico. Lo storico è, naturaliter, a pro della normalina e della logico-discorsività, e lo fa sforzandosi di distinguere i fenomeni con la massima precisione e di compararli dopo averne indicato i caratteri originali e tipici mediante il ricorso a parametri suppostamente oggettivi, definitivi, noumenici, che però è opportuno collocare nel novero delle favole.
Il tabù aveva costituito, all’alba del mondo umano (posto che vi sia stata un’alba, la quale presuppone un’aurora, e poi un meriggio e una sera… E noi, dove ci collochiamo?), l’ambito dell’erotismo; il cristianesimo esasperò il turbamento sessuale, lo stravolse, ne rovesciò il senso. Il male era la trasgressione condannata, era il peccato, e i sabbatici (gli adoratori del demonio in forma di grosso gatto, col pene enorme e scaglioso, con lo sperma gelido) si erano messi alla ricerca del peccato. I libertini (Sade per tutti) avevano negato il Male, rifiutato l’essenza del diavolo, e non restò loro, per ritrovare la voluttà del peccato, che far ricorso alla trasgressione rispetto alla società intera, non soltanto un membro di essa, la chiesa. La chiesa aveva negato il carattere sacro dell’attività erotica (che si manifestava e manifesta nella trasgressione, in essa in tal caso implicata dal momento che a dirla è la triade dei poteri) la aveva ridotta a cosa da sottoporre alla ratio, e gli «spiriti liberi» ebbero buon gioco a negare ciò che la chiesa affermava essere divino. La chiesa perdette la capacità di evocare il sacro, e gli «spiriti liberi» cessarono di credere al Male. Il mondo divenne sempre più (cristianamente) profano.
Intanto l’erotismo si era spaccato in due: da un lato quello inammissibile, l’erotismo mostruoso, libertino, atroce, infame, senza remore, immediatamente pervertito; e dall’altro l’erotismo dei buoni costumi, confuso con la procreazione, identificato con l’amore. Il suo contrario, intollerabile, venne ed è tuttora raccontato con la compilazione e la vendita dei nuovi libri monstruorum, esatto ricalco in chiave moderna (e vi si sono applicati filosofi, psicanalisti, psichiatri, psicologi, moralisti, legislatori…) dei medievali elenchi di cose diaboliche e stranezze esotiche, tutte pratiche immonde, oggi più spesso patologie: studiosi prescrutamente esperti (praticanti?) che molto spesso si sono proposti il compito di «guarire» o di punire o per lo meno disintossicare il reprovo (non da ultimo dell’omosessualità, tuttora punita in molti paesi, compresi India e Cina).
Fu affidato allo storico il compito di raccogliere, sotto un unico denominatore, le più varie manifestazioni di «diversità». Senza che mai si avvedesse che il potere deve sempre trovare mostri da combattere, e che dunque la cosiddetta perversione è una delle condizioni per la sussistenza del potere. Come lo è la «follia». Perché il potere è «sano» e dunque deve esserci la malattia psichica, dichiarata molto spesso ben più pericolosa e imperdonabile (esclude dal lavoro, dalla partecipazione attiva, dalla produzione e dal consumo) di quella organica. E sia chiaro che corpo e anima a questa stregua sono entità ben separate.
Tra le funzioni dello storico rientra quella di denunciare abusi rispetto alla Natura. Lo si vede soprattutto all’opera nella sua veste di storico della letteratura, in cui rivela appieno la sua capacità di istituire province-generi. Deve inoltre, ed è altrettanto importante, raccontare quello che definisce, esplicitamente o per sottintesi, l’«evoluzionismo conoscitivo», sforzandosi di ridurre tutto a segno – e dunque alla lettera. E lo fa convinto che «la logica, nel suo gradino più profondo, è una tautologia materiale» (Jean Piaget, Noam Chomsky, Karl Popper, Jean Monod…) Per chi sa – lo storico lo sa – che un fatto linguistico esiste solo se «possiamo parlarne». Così la poiesis, «fatto linguistico», esiste solo se possiamo parlarne. E poi, «il codice è una struttura, non un concetto» (Lévi-Strauss), e le informazioni che contiene sono scelte effettivamente dalla storia di fatti o dalla sequenza di fatti. È logico ciò che è, e già lo storico Hegel sapeva che ciò che esiste è razionale (o, viceversa, che ciò che è razionale, è).
A dimostrazione, lo storico deve di continuo rifarsi alle origini, e dunque al mitico, ma non lo sa, lo nega, dal momento che la Scienza non è il mito, che diavolo! Semmai, che ci si debba rifare alle origini è norma scritta nel nostro codice genetico, nella nostra logica che è poi la Logica: ulteriore riprova dell’unità e uniformità del mondo, secondo che detta il Consenso: le cose esistono! Esiste l’uomo! Lo sappiamo, no?, essendo che il sapere è un atto voluto, dunque registrato dallo scriba – Wollen (Knaistwolle, Machtwollen, Liebeswollen…). Essendo noto che l’uomo, arrivato buon ultimo, «alle undici della notte del 31 dicembre dell’anno dell’evoluzione», quando il più era stato fatto, e l’uomo è, non solo l’ultimo prodotto, ma anche il più perfezionato. Dalla grotta paleolitica al grattacielo. Ed è noto che la libertà consiste nel radicarsi nell’esistenza, nell’integrarsi, nell’essere dei signorsì.
Ora, lo storico che sa fare il suo dovere, che storicizza nel passato cercando il nesso esplicito con il presente (genere a sé stante), mira a una descrizione dell’uomo totale, ottenuta mediante la ricerca interdisciplinare. E lo fa, convinto che la storia sia la verità autentica della logica e della filosofia. Una delle sue convinzioni è che le ideologie – vien da dire: dunque tutto quello che sappiamo – anche se si combattono tra loro sono concordi nell’ammettere che le tecnologie sono neutrali – o tali devono diventare – e che possono fare il bene o il male secondo le intenzioni di chi le usa; sicché, l’unico errore può consistere in una ubris, in una pianificazione sbagliata, distorta (e che sia solo questo lo sanno molto bene i contemporanei della grande crisi globale, finanziaria e industriale, del 2008 e anni successivi). Del resto, lo storico non è preso dal dubbio che, siccome il testo deve essere strutturalmente coerente con se stesso, lo si possa esattamente rovesciare, affermando proprio il contrario di quanto si afferma in questo o quello, in qualunque testo. Meglio dunque la libertà del mercato o la pianificazione? Domanda alla quale è arduo rispondere, perché in ogni archivio si trova sempre un documento pronto a rispondere a qualsiasi domanda, per tendenziosa e infondata che sia. Ma poi, ogni operazione ragionevole si fonda sull’a-razionale (cui oggi si è convenuto il nome di base biologica). E in ogni testo è de-testabile perché è un inganno. E lo è in quanto figlio dell’inganno perpetrato, all’origine e di continuo, dal potere.
Il museo è il perfezionamento, l’organizzazione puntigliosa del mondo delle cose le quali, morte (gli oggetti sono tutti il passato, quindi bisogna di continuo inventarne di sempre nuovi per conferire concreta, misurabilità, al fluire del tempo) sono comunque il museo: a mano a mano che perdono utilità, si rivela infatti il loro fondamentale nonsenso (il quale fa capolinea sotto specie di «bellezza» dell’oggetto, di «forma» che sempre ne accompagna il carattere d’uso, la finalità pratica: di design più o meno volontario).
Ma, infine, lo storico si rende conto che il Sapere inquina il mondo? E che non possiamo farne a meno, se vogliamo un mondo dell’avere, della fattuità, l’unico che ci sembra accettabile, anziché annunciare l’alterità che è il ritmo insito nella Parola. Mondo della concretezza che è il contrario del simbolo, della poiesis, della Scrittura, cioè Parola che è rivelazione: un mondo dedito alle faccende, mondo degli orologi, dell’esclusiva produttività.
Rifacendosi alle origini, lo storico pretende di erigere l’edificio dell’esatta ricostruzione delle vicende, si ripromette di ripercorrere le tappe dell’avventura, del viaggio senza finalità e senza meta (lui tuttavia preferendo quello da qui a là: lo storico è un turista). Ora, le cosmogonie sono la riprova dell’inesorabile fascino delle origini, di quella contorta nostalgia che è l’attrazione della morte senza rinascita – senza re-invenzione, il suo innato «istinto» secondo il Beato Sigmund da Vienna. A differenza di chi accetta il mito (accetta cioè di rendersi conto che non può farne a meno), lo storico fa proprio il leggendario della corrispondenza tra «realtà» esteriore e «realtà» razionale, tra fatto e logos, tra pensiero e amigdala, tra esserci e strutture mnestiche, talamo e ipotalamo. Come rientra nella sua logica, e nella sua sperata salvezza, essendo lui il rampollo e l’erede del Dio Unico e Benefico, il dio che provvede e prevede, che conosce passato, presente e futuro. Il dio-favola.
Antropologia
1. Dichiaratamente, l’antropologia è una scienza. Si occupa, leggo in una qualsiasi enciclopedia, degli aspetti biologici, evolutivi, preistorici, culturali delle varie specie di Homo. Viene in generale articolata in: antropologia fisica e antropologia culturale. La prima ha per oggetto le caratteristiche biologiche ed evolutive, in altre parole il corpo, gli aspetti somatici dell’uomo, mentre la seconda si occupa di quelle manifestazioni che non sono biologicamente (o geneticamente) programmate, e pertanto attengono al pensiero. È dunque evidente che l’antropologia parte dalla distinzione tra corpo e mente ben radicata nella cultura occidentale. Se poi al termine mente si sostituisce spirito o addirittura anima, risulterà palese che si è di fronte al tradizionale dualismo tra scienza laica e scienza teologica. Del resto, soprattutto la dottrina cattolica parla spesso e con convinzione di antropologia.
Sarà opportuno ricordare che, come credo di aver accennato e convalidato, la prima scienza, la laica, è figlia diretta della teologica, o meglio, per dirlo con Charles Morazé, si ha a che fare con Le Origines sacréas des sciences modernes (Fayard, Parigi, 1986).
Il fondamentale dualismo della ricerca antropologica risale all’origine stessa di questa scienza, che cominciò a prendere necessariamente forma quando la cultura europea si trovò di fronte al «nuovo mondo», sentì la necessità di descriverne e valutarne gli aspetti, e si convinse che non fosse possibile affrontare le etnie prima sconosciute o ignorate con i metri di misura correnti nel mondo occidentale, quello per eccellenza del Discorso e del dominio del logos. Occorreva una etnologia che fosse l’equivalente della visione colonialista, senza minimamente rinunciare ai principi del logos. Quest’etnologia almeno all’inizio si basò molto spesso sui resoconti di esploratori e missionari in veste di civilizzatori, quanto dire distruttori delle culture locali o per lo meno artefici della loro sottomissione e trasformazione. Per ottenere che seguissero punti di vista e metodi fedeli all’antico schema del superamento, assorbimento e cancellazione del mitico nelle sue più varie accezioni a opera del logos egemone.
Penso che il modo più esplicito di chiarire insieme la genesi dell’antropologia e l’atteggiamento generale della cultura logico-discorsiva nei confronti delle altre culture, sia di rifarsi alla concezione che quella occidentale (ma con essa le culture che ne hanno subito l’influenza e si sono di conseguenza «modernizzate») si fa dell’arte. Termine con il quale per lo più si designano due evidenze: la produzione degli artisti professionisti, e la considerazione della quale questi sono oggetto. Nell’insieme, esse comportano un condizionamento del pubblico e degli esperti d’arte tale da indurli a ritenere che soltanto le opere esposte in musei e gallerie, descritte e riprodotte in cataloghi o libri d’arte, insegnate in apposite scuole – quelle cioè che rispondono al codice referenziale, cioè agli stessi mezzi espressivi dei professionisti e degli «addetti ai lavori» – siano effettivamente accettabili a pieno diritto e da dichiarare artistiche.
D’altra parte, questi stessi «addetti» o «specialisti» si rendono conto che nell’universo dell’anonimato, dell’«astorico», del «primitivo», persino nelle espressioni dei bambini, dei reietti, di quelli che vengono etichettati come folli, è dato di imbattersi in esempi (a volte volutamente tali, più spesso involontari, casuali), di libera e a volte straordinaria invenzione.
La cultura occidentale, il Discorso, queste manifestazioni le ha tenute a lungo alla larga. È stata indotta a prenderle in considerazione da una serie di fattori soprattutto economici (le espressioni dei primitivi a volte scandalizzano o orripilano, ma hanno non di rado un valore monetario), all’inizio indicati da ammiratori o apprezzatori del «diverso» e dell’«insolito» e convalidati dalle affermazioni di artisti delle cosiddette avanguardie, i quali hanno osato proclamare che queste opere di arte non-artistica suscitavano, non solo curiosità, ma anche altre emozioni, entusiasmi, commozioni, eccetera. Si è giunti così a definire per lo meno «singolari» e «originali» queste produzioni, dette «non utilitaristiche» in mancanza di altri termini, e si è finito per annoverarle tra i prodotti di quella che gli esperti definiscono «arte» sebbene nessuno, che si sappia, sia in grado di dichiarare che cosa essa sia.
Le arti africane e oceaniche erano state a lungo ritenute degne al più di interesse appunto etnologico, in obbedienza alla radicata convinzione del mondo civilizzato, quello per lo più definito occidentale, della propria superiorità che lo autorizzava – e tuttora lo autorizza – a giudicare il resto del mondo e a condizionarne gli sviluppi. E se produzioni artistiche non occidentali sono state accolte, è solo perché artisti ritenuti tali o esperti riconosciuti a esse hanno attinto (cubisti, surrealisti, espressionisti, nordici…) Fenomeno che è andato di pari passo con la distruzione delle rispettive culture, sottoposte alla colonizzazione quando non al massacro, al punto da far sembrare giustificata l’affermazione di Richard Wagner, che «l’arte comincia dove finisce la vita».
2. La stessa cosa è accaduta con l’antropologia, scienza che tra l’altro attribuisce grande importanza alle espressioni artistiche delle etnie visitate ed esaminate. E se oggi è in corso un’idealizzazione dei prodotti non-utilitaristici etnici, e più genericamente popolari, è accaduto perché l’occidente ha aperto – con mille precauzioni – al «primitivo», al «selvaggio», all’«estraneo». Tenendo sempre fermo il principio della propria indefettibile superiorità.
L’interesse antropologico per l’«altro», la celebrazione delle esplorazioni, l’enorme produzione editoriale tra Ottocento e Novecento di libri di viaggio e narrazioni avventurose, è andato via via sfumando in curiosità turistica, e la produzione e editoriale si è praticamente ridotta alle guide di viaggio. Nel frattempo, le separazioni e specializzazioni etnoantropologiche sono andate avvicinandosi e mescolandosi. Oggi si tende a considerare l’antropologia una metascienza dell’uomo, una raccolta di compilazioni di dati non sempre organizzati, di fonti diversissime, rispondenti a punti di vista disparati, comunque intese a fornire alla cultura ufficiale un quadro quanto più possibile vario, anche se non sempre esauriente, di altri mondi umani.
Donde, anche, la trasformazione o meglio dilatazione dell’antropologia culturale. La quale sta sempre più diventando una sintesi di interpretazioni in continuo divenire e in stretto rapporto con altre scienze, come psicanalisi, psicologia, semantica, ecologia, a comporre un vasto insieme che ha inglobato molte tradizionali discipline separate, come antropometria, paleoantropologia, etologia, biologia, ecc. Largo spazio è oggi dedicato all’acculturazione (problema del resto promosso dall’afflusso di extracomunitari d’ogni genere), all’assimilazione, al folklore e soprattutto alla trasformazione ab interno delle società di accoglienza, che stanno decisamente e ampiamente diventando polis-centriche, metropoli-centriche e sempre meno «naturali».
3. I principi metologici dell’antropologia restano però sostanzialmente gli stessi: alla fase di raccolta dei dati, nella quale com’è ovvio intervengono vari modelli che comunque rispondono alla visione iniziale del procedimento, si sono imposti due principali sistemi, due scuole di pensiero, una delle quali si traduce nell’applicazione agli oggetti della ricerca di strutture mentali, di una griglia sovrapposta agli oggetti stessi, inevitabilmente trasformata, a mano a mano adattata, adeguata, recentata, trasformata, per coprire l’estensione del progetto di ricerca. Questo è il metodo strutturalistico, reso celebre da Lévi-Strauss, e che in pratica si riduce all’applicazione di alcuni principi ritenuti validi per tutti gli esseri umani. Come s’è detto a proposito della favola (pp…………….), è un artificio che comporta una notevole dose di casualità. Se la «griglia» eccede o è insufficiente, quale certezza si potrà avere che non venga artificiosamente alterata? E soprattutto, quale certezza si potrebbe avere che alcuni principi siano validi per tutti gli esser umani? Il sospetto dell’illusione o addirittura di un gioco di bussolotti, diventa legittimo.
L’altro metodo consiste in ricerche particolarmente accurate, dalle quali risultino equivalenze o somiglianze tra i gruppi umani, tali da permettere di collocarli in caselle: di ordinarli, in altre parole, in categorie di corrispondenze. Ne dovrebbe derivare una definizione di uomo.
Le differenze tra il metodo strutturalista e questo, comunque assai minori di quanto può sembrare a prima vista, è che lo strutturalista è aprioristico, mentre il secondo, che vorrei definire naturalistico, basato sui principi della zoologia o della botanica, parte a sua volta da un a-priori, quello della classificabilità e dunque della riduzione a categorie delle differenze dei singoli – individui o gruppi – e della sottolineatura di caratteristiche ritenute essenziali, esattamente come si fa con i generi, le famiglie, le specie, iphila.
Il metodo strutturalista è più moderno, il metodo naturalistico risponde a una visione più tradizionale. Nell’uno come nell’altro caso, a venire sacrificata è però sempre la singolarità a vantaggio dell’inquadramento. Entrambi i metodi, poi, appaiono giustificati in quanto prevalentemente impiegati nei confronti di realtà extraoccidentali; in fin dei conti in pratica non vanno molto al di là – e non sono poi molto più esaurienti – delle definizioni, che so, di pellerossa, indio, pigmeo, negrito, persiano, siberiano, mongolico, e via dicendo. Definizioni accettabili negli scambi correnti, scolastici, casermieri, parrocchiali, regionali… Ma che comprovano l’impossibilità per l’antropologia (o per le scienze in generale?) di trascendere la genericità e di offrire una visione «umana» delle realtà con cui si trova alle prese il cultore della scienza.
Ma le genericità (costui è «italiano», quell’altro «libico»…) non illustra niente. Resta confinata pressapoco nel provvisorio, nel pregiudiziale. Equivale al tentativo, vano a priori, di definire, che so, l’uomo italiano o senegalese: tentativo che neppure un romanziere oserebbe affrontare.
D’altronde, l’antropologia è letteratura a pieno diritto. E la sua funzione non è diversa da quella della cronaca che, come ho detto, è stata ed è tuttora al servizio delle conquiste. L’antropologia, che assegna ai singoli livelli di validità, finisce per essere un esercizio di indicazione quasi esclusivamente biologica, dal momento che il ricercatore deve arrestarsi di fronte alla non-interpretabilità dell’osservato, violata soltanto dalla classificazione.
L’antropologia nulla chiarisce, nulla spiega, non individua ragioni e risultati di attività che trascendano le banalità sintattico-grammaticali, che non ricadano nel recinto della linguistica. L’antropologia espone una favola, quella della riduzione all’uno della molteplicità umana.
3 Conosciamo null’altro che l’immaginario.
Ritengo inutile imbarcarmi in una delle sterili contese sulla validità di questa o quella delle numerosissime teorie antropologiche . Che considero sterili perché, dotte e particolareggiate come indubbiamente sono, mancano affatto di partecipazione e calore umano. E, soprattutto, tacciono su ciò che definisce un essere umano. Si affannano a fornirne indicazioni senza mai rispondere alla domanda che dovrebbe presiedere a tutte codeste ricerche, ed è: l’essere o l’esser-ci dell’uomo si presta a venire asserito e comprovato?
La risposta presupporrebbe una definizione di uomo. È certamente facile, almeno in apparenza, sostenere l’esistenza – la presenza davanti ai nostri occhi – di quegli esseri che chiamiamo uomini. I quali si muovono, parlano, gesticolano, rispondono a domande, interpellati replicano, li riconosciamo, ci riconoscono, sono evidentemente dotati di emozioni, sentimenti, pensieri, e prima ancora di un corpo che fa da cassa di risonanza a questa loro interiorità. La quale è considerata la riprova dell’umanità del genere Homo. «Sappiamo» con assoluta certezza che gli individui della specie umana nascono e muoiono e che hanno una incerta durata. Ma ci è impossibile stabilire con certezza, toccare con mano, fornire conferme che non siano semplici supposizioni o affermazioni dettate da convinzioni d’ordine razionale – «è così, non può che essere così» – quando e come la vita cominci e quando e come abbia (debba avere) fine.
Le nostre convinzioni si basano su probabilità, le quali sono tutt’altra cosa di una realtà noumenica assoluta e definitiva. Dobbiamo attenerci a evidenze fenomeniche. E, va detto subito, è quanto ci accade in tutte le sfere del «sapere». Delle certezze che supponiamo di possedere in forza di un atto di fede e di un Wollen, un voler-sapere, un voler-accettare le nostre convinzioni. Ancora una volta, come ha già detto a proposito delle certezze scientifiche, tutto si basa sulla probabilità razionalmente accettata della sovrapponibilità di documento ed effettualità, di cartografia e terreno. In altre parole, sull’identità, da noi sostenuta, di ratio e fede.
Ora, la certezza della nostra esistenza (del nostro inizio, della nostra probabile fine, della zona intermedia tra l’uno e l’altra) ci viene dalla constatazione che così accade a tutti i nostri simili. Ne consegue che la «realtà» della nostra esistenza, del nostro esser-ci, non è sperimentabile singolarmente. Ma non lo è neppure l’esistenza del prossimo, se non in base a ciò che abbiamo convenuto di prendere per certo in obbedienza alla tradizione: una certezza storica.
Ma allora, quando è cominciata, e come, la certezza in questione? Quando ha avuto inizio la storia, – cioè la concezione di un tempo fatto di momenti in successione – che è la roccia sulla quale nel corso di millenni abbiamo edificato l’edificio delle nostre certezze, del nostro sapere? La storia ci appare quale una scomparsa di configurazioni di un certo tipo (siamo noi a definirle tali), che ci appaiono diverse da quelle che si succedono in un corpo altrui e in situazioni differenti. In un parola, noi sperimentiamo (vediamo) la carne dei nostri simili, e ne deduciamo che così sia anche la nostra carne. Ma ci sfugge, ed è impossibile attingervi, la visione, la sperimentazione (tattile, sensibile, odorosa, udibile, inconfondibile, assoluta e definitiva, della Carne – con la «C» maiuscola –, al di là del nostro atto di fede.
Questa Carne sempre ci sfugge. Non la si coglie né nel vivo né nel morto. Non la coglie l’anatomo, non la coglie il cannibale. Non la coglie il samurai che pratica il seppuku proprio per impadronirsi della Carne (per affermarne e imporne la presenza, per punirla, per esaltarla, per sottrarsi all’incertezza circa il suo esser-ci) e può magari sperare di «sorprenderla» nelle viscere che squarcia con la spada ed estrae dal presunto se stesso. Né coglie la Carne qualsivoglia altro suicida, che fino all’ultimo dialogherà con la pallottola che lo stermina, con la corda che lo strozza, senza poter uscire dalla cognizione che ha in quanto corpo-pensiero.
Anzi, si può dire che in larga parte il suicida è impulso proprio dalla brama di sottrarsi all’incertezza costitutiva, al presunto perché delle proprie insoddisfazioni, infelicità, senso di inutilità che avverte, che suppone di sperimentare in misura definitiva, non potendo accontentarsi della voce della ragione – che sa perfettamente, che constata, magari infintandosi di ammetterlo, essere un «sogno» non diverso dagli eventi onirici che lo assillano o consolano nel sonno. Perché le immagini, le forme, i suoni, le verbalità che la ratio gli propone durante la veglia sono in effetti immotivate quanto le fantasie delle fasi oniriche.
La Parola, ripeto forse per l’ennesima volta, non ha origine. Si manifesta, si impone, a volte invocata, cercata, promossa, altre del tutto inaspettata, uscente da quella sorta di buchi neri (senza luce, senza perché) che sono i vuoti di memoria.
E la Parola è increata. Nessun dio ce la mette in bocca, nessun dio la pensa-pronucia per noi.
Ma la stessa fine, del singolo e delle cose, è in effetti un arbitrio, una supposizione, una convinzione, una scommessa. L’annientamento della carne e degli oggetti, se in apparenza può sembrare quanto mai evidente (e lo stesso vale per la presunta uscita dal niente dei viventi e delle res, che è a sua volta – e per l’ennesima volta – un atto di fede. Le religioni, che vogliono essere la riprova e la certificazione delle nostre supposizioni (e non sono che atti di fede obbligatoriamente tali – ne parlerò in un prossimo paragrafo), la convalida cioè della triade costitutiva del dominio (si veda pp…….), l’imposizione dogmatica della affidabilità della ratio metafisica, hanno inventato volta a volta la resurrezione di corpi o la transizione ad altre dimensioni, il samsara oppure il nirvana.
So quanto sia difficile accettare che noi, e ogni altra cosa vivente o meno, non abbia senso, non abbia ragione di esistere, non abbia necessità, e che in sua assenza nulla muterebbe («tutta la vita è senza mutamento», finiva per constatare il vecchio Gabriele D’Annunzio). Pure, mi sembra che accettarlo sia un atto di saggezza o, se si vuole, di inevitabile rassegnazione. E soprattutto, di coraggio e dignità.
Un confronto. Lo propongo tra la riduzione all’uno dell’antropologia come cronaca al servizio delle conquiste, e in sostanza la sua inevitabile tendenza a inventare esseri umani di comodo – a farsi favola – e una visione ben diversa degli stessi esseri umani. Specificamente il confronto è tra la concezione del tabù in Lévi-Strauss e un racconto tratto da Il Decamerone nero di Leo Frobenius.
La differenza essenziale tra questi due testi consiste nell’essere uno, quello di Lévi-Strauss, un astratto esercizio di applicazione di una dottrina, l’altro, il racconto africano, è il frutto sia pure discutibile (e tra poco dirò per quale ragione) di un viaggio, uno dei tanti di Frobenius, in Africa.
Frobenius (1873-1938), anch’egli XXX a cogliere la presunta «identità» di un mondo «selvaggio», in questo caso un intero continente, ha trascritto i racconti di varie etnie africane, cogliendoli dalla viva voce dei dialli e dei mabo, i cantastorie di regioni diversissime, dalla Cabilia alle foreste del Togo, dalla regione dei Grandi Laghi e della cultura XXX, a quelli che sono oggi la Nabibia, il Botswana, il Sudafrica, lo Zimbabwe e il Mozambico. Dieci viaggi compiuti da Frobenius dal 1904 al 1932, in un’Africa in cui certe zone conservavano per lo meno il ricordo di un’altra epoca, di culture non ancora devastate dal Colonialismo e dalla civiltà che viene detta moderna. Conscio che la loro residua integrità sarebbe stata ben presto cancellata, Frobenius ne raccolse i resti irripetibili in alcuni esemplari raccolti, come i dodici volumi della Summlung Atlantis e i tredici di Und Afrika sprach… Forte di queste ricerche, all’epoca in cui insegnava a Francoforte ed era direttore del Museo etnografico di quella città, scrisse un libro di estremo interesse, Storia della civiltà africana, pubblicato in Italia da Einaudi nel 1950.
Indubbiamente, contributi preziosi al «viaggio» di un’intera vita, almeno a parole senza finalità di dominio, ma rispondente per sempre a una visione etnocentrica, quella di un’Europa che visiti il mondo dei «selvaggi» e ne ricavi reperti, sorprese, incantesimi: un’Europa traduttrice, e Frobenius infatti questi suoi reperti li tradusse in tedesco, per essere successivamente traslati in numerose altre lingue. Con l’aggiunta di un tentativo di interpretazione complessiva, di cogliere l’essenza di un intero continente, secondo il principio che Frobenius definiva della «morfologia storica». Che era il rifiuto della storiografia come funzione consistente nella distinzione e nell’ordinamento. Cioè, proprio l’ufficio dell’antropologo come storico che è sempre stato quello di Lévi-Staruss e di tanti altri indagatori di visioni del mondo diverse da quelle delle accademie d’ogni parte del mondo.
Ovviamente, Frobenius è stato oggetto di accuse e deprecazioni da parte della cultura ufficiale che, per quanto attiene al capitolo antropologia, è tuttora legata al positivismo oggettivo. Frobenius è stato ovviamente accusato di nazionalismo, di fedeltà a una visione della storia come intuizione. O, per meglio dire, come apertura e abbandono, come empatia. Se vogliamo, Frobenius (pur nei limiti di una visione della mitologia africana in termini logico-discorsivi – ma che altro potrebbe essere la trasposizione dalla scrittura orale in una lingua connotata dal rispetto del logos?) è stato un traduttore che si è opposto all’idea della trasposizione de testi di partenza a testi di arrivo come soluzione di un problema matematico. I cui assertori hanno fatto osservare che siffatta visione, se si vuole «artistica» dell’antropologia, della storia come intuizione, ha avuto conseguenze disastrose nel primo terzo del XX secolo: quando l’«intuizionismo» sarebbe sconfinato in «certi miti», specialmente cosmici e astrali… varianti di miti antichissimi scaturiti anche in occidente dalle emozioni di un’umanità primordiale: si pensi a Rudolf Otto, a J.M. Hauer, a Walter Otto, Karl Kerényi. Non faccio che ripetere le accuse alla Storia della cultura africana e al suo autore mosse dallo stalinista Ranuccio Bianchi Bandinelli, risoluto avversario di un’arte come «commozione» XXX matrice dell’astrattismo, dell’arte «XXX», e di vari rifiuti della razionalità.
Perché si tratta di una contrapposizione pur sempre in atto, più che mai rivolta, quella inconciliabile tra semantica-linguistica e pòiesis, fra Letteralismo e Scrittura, non mi resta che istituire il confronto di cui all’inizio del paragrafo.
Ecco dunque l’idea di tabù di Lévi-Strauss, che lo considera tutt’uno con proibizione, e dunque di carattere legalistico, e una storia del Cordofan, sentita e trascritta da Frobenius e da lui intitolata La riconoscenza di Mussa. È reperibile ne Il Decamerone nero (p. 223 sgg.) e in Storia della civiltà africana (ediz. Italiana, p. 490 sgg.).
Il tabù secondo Lévi-Strauss e le sue carenze.
Ognuno di noi occidentali sa che il cannibalismo non è ammissibile (è uno dei soli principi su cui si basa la stanzialità in una con di divieto dell’ itinerantismo), che l’orgia è sconveniente, che il cadavere è intriso di sgomenti, ognuno di noi avverte la decomposizione come un atto di aggressione, di una violenza intollerabile che lo spegnersi della debole fiamma della vita ha scatenato. L’interdizione dell’uccidere non è che un aspetto particolare del tabù globale contro la violenza, per scatenare la quale introducendolo nel mondo organizzato del lavoro, della procreazione programmata, della produzione di beni – insomma nel mondo profano – occorre un atto di disordine, un’azione insoluta, la soppressione, diretta o per opera di magia o di credenza di esseri superiori, d’uno o più partecipanti allo sforzo collettivo ordinato; sicché, nell’ambito della collettività la violenza è tabù, mentre è sottoposta a interdizioni più facilmente «levabili» nei confronti del mondo esterno. Le compete pur sempre la sacralità (da sacer nella doppia accezione, di sovrumano e di maledetto).
Ma cosa dunque si intende per tabù? La domanda stessa è mal posta, perché presuppone un oggetto della conoscenza, appunto il tabù, un soggetto, segnatamente quello dell’uomo moderno, che dei tabù si sarebbe liberato o starebbe liberandosi o per lo meno potrebbe contemplare il fenomeno dal di fuori, con scientifico distacco. Né l’ostacolo viene superato dal tentativo, compiuto per esempio dalla psicanalisi, di «pensare il soggetto della conoscenza». In effetti, il soggetto non è che il termine complementare dell’oggetto, e di per sé è inafferrabile. Le teorie come la psicanalisi (e la psichiatria) presuppongono invece la sostanzialità del soggetto, una sua «realtà» che poi si riduce, oggi, alla descrizione di «strutture» psichiche, termine che inevitabilmente rimanda a realtà fisiologiche e comunque oggettive (cervello, sistema nervoso, ecc.).
Sarebbe dunque opportuno ripercorrere le principali concezioni del tabù, per determinare il posto che in esse occupa il punto di vista di Lévi-Strauss. Dalle quali risulta, come si vedrà, che il tabù non è «conoscibile», ma è pure immediatezza: che cioè le considerazioni sul tabù al pari di quelle sulla Parola, esprimono oggetti di sostanza; sono dunque espressioni improprie, tentativi di decretare (o circoscrivere), in maniera sempre insufficiente, l’intoccabile e l’indicibile, ciò che «appare».
Donde quella che sembra l’estrema variabilità culturale del tabù e il fatto, che tanto colpisce gli osservatori, che esso possa venire proclamato e instaurato; ancora, la sua estrema volatilità, il suo continuo tendere a tradursi, sotto gli occhi dell’antropologo incapace di fissarlo in una cristallizzazione definitiva, in norme e regole, a generare una grammatica e una sintassi del proibito.
Molti antropologi hanno voluto scorgere, almeno fino alla XXX del XX secolo, una convergenza fra la situazione del tabù e il presunto preanimismo, termine coniato dagli assertori dell’indirizzo evoluzionistico per indicare forme di credenze nel superumano ancora più primitive dell’animismo. E si è creduto di constatare che la trasgressione dei divieti sacrali, cioè del tabù (e in questa concezione era, ed è, implicato che il tabù sarebbe senz’altro di spettanze del divino, dell’extraumano) proclamasse sanzioni automatiche, spesso persino la morte del trasgressore. Altri hanno ricollegato il tabù al totemismo, affermazione smentita dalla constatazione (e ogni «legge» scientifica è valida solo a patto che nulla venga a smentirla che tra gli aborigeni australiani non si hanno tabù totemici, mentre i tabù in generale sarebbero, a detta degli antropologi, numerosi e fortissimi.
Un’altra concezione vorrebbe correlare il tabù alla presunta categoria del marra, una carica di potenza sovrannaturale, positiva perché la possiede e da evitare da altri che potrebbero essere XXX. Si potrebbe assimilarla all’idea del baraka diffusa in certe zone del mondo islamico (per es., Marocco), che sono ricollegabili a quello che si usa chiamare il carisma di una persona influente, o addirittura al sex-appeal. O ancora, al «magnetismo» attribuito a persone di elevate capacità politiche, a trascinatori di folle, per es. a Stalin, a Lenin, a Hitler, a Roosevelt, ecc. Il tabù sarebbe allora una qualità vagante, un ente fluttuante, frutto di una «dichiarazione» o «indicazione» o «definizione» di cui lo studioso potrebbe, con un po’ di attenzione, ricostruire la sintassi, la grammatica del tabù (la cosa o la persona o la situazione che è bene non toccare) da far eventualmente risalire a necessità pratiche, economiche.
Così per esempio il tabù che copre la carne di maiale in ambito giudaico avrebbe antiche ascendenze igienistiche (nel clima del Medio Oriente farebbe male mangiarla), XXX a caldo che popolazioni tropicali o subtropicali se ne nutrono abitualmente (Polinesia, Filippine, India del Sud…).
Allo stesso modo, il tabù dell’incesto sarebbe riconducibile alla necessità dello scambio delle donne. Leggiamo in merito appunto Lévi-Strauss: «La proibizione dell’incesto così come l’esogamia che è espressione sociale allargata, è una regola di reciprocità. La donna che ci rifiutiamo o ci viene rifiutata è per ciò stesso offerta. A chi? Ora a un gruppo definito dalle istituzioni, ora invece a una collettività indeterminata è sempre aperta, limitata soltanto dall’esclusione dei congiunti prossimi, come appunto avviene nella nostra società. Ma riteniamo che… sia possibile trascurare le differenze tra la proibizione dell’incesto e l’esogamia: in effetti… i loro caratteri formali risultano identici.
«C’è di più: sia che ci si trovi nel caso tecnico del XXX detto ‘per scambio’, sia invece che si abbia a che fare con un qualsiasi altro sistema matrimoniale, il fenomeno fondamentale che risulta della proibizione dell’incesto è il medesimo; a partire dal momento in cui mi vieto l’uso di una donna, che così diviene disponibile per un altro uomo, c’è da qualche parte un uomo che rinuncia a una donna che, perciò, diviene disponibile per me. Il contenuto della proibizione non si esaurisce nel fatto della proibizione: quest’ultima viene stabilita soltanto per garantire e fondare, direttamente o indirettamente immediatamente o mediatamente, uno scambio.» (il corsivo è mio).
Passo esemplare e inequivocabile. In primo luogo, l’atto (lo scambio) di cui in Lévi-Strauss, e dunque il tabù dell’incesto, che avrebbe un fondamento utilitaristico. In secondo luogo, ciò avverrebbe in una società. Come dirò in un paragrafo successivo, dedicato al Neolitico, tra i gruppi umani, le società sono apparse assai tardivamente nel corso della loro vicenda (della loro storia). E le società non esistono, tutt’oggi, tra i cosiddetti selvaggi o primitivi. Per la semplice ragione che la società è organizzata, è frutto di una scelta, di una volontà, e nient’affatto naturale. E poi l’ultima, fondamentale ragione, ed è che la società è sempre gerarchica, piramidale e basata sulla disuguaglianza dei suoi componenti, innanzitutto sulla disparità tra governatori e governati e, ancora una volta dal Neolitico, tra uomo e donna. Quanto al fondamento utilitaristico teorizzato da Lévi-Strauss esso sarebbe condizione dell’esogamia, superiore all’endogamia «che è un principio inerte di limitazione, incapace di superare se stesso». Ancora, le donne in queste descrizioni sono soggetti passivi, e neppure si contempla la possibilità che a decidere dello scambio e delle sue modalità non siano i maschi. 8Cosa che contrasta con l’evidenza dei superstiti «primitivi» tra i quali a comandare, scegliere, prescrivere, non sono sempre e soltanto i maschi).
La cultura, poi, in questa visione di Lévi-Strauss, è concepita come ambito della totale comunicazione. E Lévi-Strauss non è neppure sfiorato dal dubbio che l’espressione, di cui a conti fatti consiste la comunicazione, ha, sì, carattere manifestante, di aggiunta alla chiarezza, conoscibilità e conoscenza, ma questo non la esaurisce: l’espressione non si conclude nelle parole del Discorso e neppure nei protolinguaggi nei quali rientrano anche gli scambi in generale, e quello dei doni in particolare (e il concetto di dono è alla base di quello di scambio in Lévi-Strauss), ma essa rimanda a qualcos’altro, a qualcosa che sta sotto e prima: non tutte le espressioni hanno infatti una rappresentazione. La Parola è pensiero, che diviene parola quando è espresso. Esistono atteggiamenti (e linguaggi) che sono significativi ma non significanti, non intesi alla comunicazione. L’arte è espressione di un’espressione, non però di un oggetto rappresentativo. L’arte, cioè, espira, come ultima istanza, al silenzio, alla consumazione (non oggettuale, non res), anziché alla comunicazione. L’arte non ha senso, non indica. Non ha scopo al di fuori dell’arte stessa.
Bisogna, a questo punto, rifarsi all’«efficacia simbolica» di un’altrove (Antropologia strutturale)parla Lévi-Strauss. L’«efficacia simbolica» consisterebbe appunto in una ‘proprietà induttrice’ di cui, le une rispetto alle altre, sarebbero dotate di strutture formalmente analoghe, edificabili, con materie prime differenti, ai diversi stadi del mondo vivente; processi psichici, psichismo collettivo, pensiero riflesso. La metafora poetica fornisce un esempio familiare di questo procedimento induttore; ma il suo reso abituale non le permette di superare la sfera psichica. Constatiamo così il valore dell’intuizione di Rimbaud che affermava che essa può anche servire a mutare il mondo (cioè, annoto io, a farsi arte ingagée, arte al servizio di).
In Lévi-Strauss, questo concetto delle «strutture formalmente analoghe» è, com’è noto, fondamentale: l’articolazione di natura e cultura non riveste l’interessata apparenza d’un regno gerarchicamente sovrapposto a un altro cui il primo sarebbe irriducibile, ma piuttosto quella di una ripresa sintetica, consentita dall’emergere di certe strutture cerebrali appartenenti anch’esse alla natura, di alcuni meccanismi già montati, che però la vita animale presenta solo in forma slegata e concede solo in ordine sparso (Strutture elementari, [il corsivo è mio]). In altre parole; la coscienza umana riflette certe strutture presenti nella natura; essa è il luogo in cui tali strutture si XXX. Lévi-Strauss incappa dunque in una duplice o triplice metafisica; si riconduce alla biologia (scienza umana, a mio giudizio ricavata tale e quale dall’evidenza naturale); «conosce» il soggetto; e suppone le strutture del soggetto, inteso come sostanza o almeno come specchio, secondo la concezione di tutta la filosofia occidentale; e ribalta questa presunta essenza (la quale, ripeto, deriva dal contenuto della scienza biologistica, che è XXX XXX, non già fatto di natura) sul mondo. Davvero l’antropologia è, inevitabilmente, razional-cristiana. Cioè una favola.
Ma Lévi-Strauss non si ferma a questo punto. Fedele all’idea (che è poi il presupposto della sua antropologia) delle strutture coscienziali e conoscitive che replicano quelle naturali, afferma «che la proibizione all’incesto costituisce una regola, un fatto che non richiede dimostrazioni»; basti ricordare che il campo di applicazione del divieto del matrimonio tra parenti prossimi può variare a seconda del modo con cui ogni gruppo XXX che cosa esso intende per parente prossimo, ma che questo divieto è sempre XXX in qualsiasi gruppo sociale, pur se è sanzionato da penalità che sono indubbiamente variabili, e che possono andare dalla esecuzione immediata dei colpevoli alla riprovazione diffusa e talvolta soltanto alla derisione» (Strutture elementari [il corsivo è mio]).
Nelle centinaia di posizioni delle Strutture elementari si trovano scarsissimi accenni ai clamorosi casi di infrazione del tabù: i sovrani (d’accordo, arcaici, e quelli moderni non fanno certe sconcezze: c’è il progresso, no?) che sposavano sorelle o addirittura la madre, sono stati così numerosi, da indurre a credere che questa fosse, presso le società «antiche», la regola. Basti pensare agli Incas e ai re egizi. Ma ascoltiamo ancora Lévi-Strauss: «Gli uomini scambiano culturalmente le donne, le quali perpetuano questi stessi uomini naturalmente; ed essi pretendono di perpetuare naturalmente la specie che scambiano sub specie naturae: cioè, sotto forma di prodotti alimentari sostituibili gli uni con gli altri in quanto sono cibo e in quanto – il che vale anche per le donne – un uomo può essere soddisfatto di certi cibi e rinunciare ad altri, nella stessa misura in cui qualunque donna o qualsiasi cibo è ugualmente idoneo a servire ai fini della procreazione e della conservazione» (Il pensiero selvaggio [il corsivo è mio]). Dove, evidentemente, la possibilità di scelta è ancora una volta esclusa; e dove, peggio ancora, si confonde erotismo con procreazione (le donne «servono a procreare»). E d’altra parte «nulla può impedire che [le donne] si differenzino tra loro nella loro essenza animale, che le rende diversamente desiderabili per il marito» (L’origine des manieres de XXX [il corsivo è mio]). E infatti Lévi-Strauss scopre, negli indios, «una immensa gentilezza, una profonda indifferenza, una ingenua e delicata soddisfazione animale» (Tristi tropici, edizione italiana [il corsivo è mio]).
Se ne deve dedurre che, per Lévi-Strauss, il tabù dell’incesto «funziona» per conto suo; e nulla, evidentemente ha a che fare con altri tabù: l’itoccabilità del morto (oppure l’identificazione con il corpo, persino con i liquam della sua XXX), il tabù che sempre copre l’erotismo, la proibizione di accedere a certi luoghi o toccare certi oggetti, ecc. Ma gli sfugge (e penso volutamente, per tener fede al suo principio delle strutture elementari) che il divieto, sia in forma di interdizione voluta, programmata, o di un tabù spontaneo, immediato, non solo possa, ma anzi debba mutare di continuo. Per la semplice ragione che il tabù è per il fatto di essere violato. E solo allora se ne percepisce l’astanza, quella di una sbarra XXX che prontamente piomba alle spalle di chi ha superato il confine alzando la sbarra. Gli è che il tabù non è una «cosa», bensì uno stato d’animo, un sentimento, una apparizione un phanes – che indissolubilmente accompagna la Parola, il mitema, il pensiero che è Parola.
Comunque, dappertutto si viola il tabù. Lo viola la madre australiana che si congiunge col figlio dall’infanzia all’adolescenza, quando cessa di «essere-con la madre» e diventa «del gruppo», cioè procacciatore attivo di cibo, difensore del gruppo stesso, cacciatore, dipintore di immagini su terra o su pareti sotto roccia, e quindi deve distaccarsi o venire distaccato dalla madre. E avviene senza trauma, a smentita dall’XXX freudiana dell’Edipo. E lo stesso avviene tra madre e figlio tra i Kaingang brasiliani, che dimorano e itinerano in zone vicine a quelle frequentate dagli indiani brasiliani del Panamà, visitate e descritte da Lévi-Strauss, al quale pure i Kaingang son sfuggiti.
Aggiungo ancora una annotazione, e poi passo a Frobenius e alla sua visione dell’Africa dove vivono esseri umani che raccontano (fiabe, certo) ma non solo invenzioni logico-XXX di persone fatte oggetto di indagini pre-ordinative.
È facile constatare che tutte le cose coperte dal tabù in qualche modo ci turbano, inquietano, opprimono, XXX, angosciano… O, per meglio dire, dietro a esse sempre ci appare una manifestazione, alcunché di nascosto.
È come se il tabù fosse un faro attraverso il quale spingere lo sguardo in un ambito insolito, un «reame pericoloso» al quale vorremmo accedere anche se – i più svagati tra noi – si rendono conto che l’aldilà è sempre e soltanto parola. Ma, come dirò più avanti, dal Neolitico in poi molti di noi sono convinti (a parte quelli che papa Ratzinger, pontefice dell’epoca in cui vengo XXX mie note impronte di XXX e cinismo) di poter andare,come Alice nelle Wonderland, al di là dello specchio dietro il quale vediamo il nostro modo di pensare, le nostre favole – noi stessi chiamiamole pure ideologie, per quanto attiene alla loro versione in politichese. E senza le ideologie, scientifiche, religiose, ecc. ecc., saremmo rimandati a emozioni, passioni, armonie. E si sa, lo sapeva Goethe, che «la mancanza di ideologie è la peggiore delle ideologie». Senza favole, come faremmo a muoverci nel mondo?